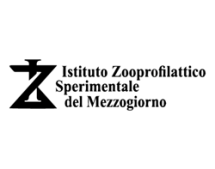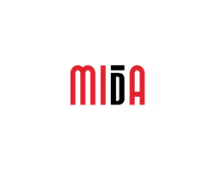di Pasquale Simonetti.
Il nostro pianeta Terra è vivo e vivente, un sistema naturale, aperto, ciclico, ricco, anche usato, o meglio abusato, violentato e, a volte, disastrato.
Lo studio retrospettivo e l’approfondimento di politiche, strategie, piani di azioni, articoli, dichiarazioni, linee guida portano a riflettere sulle principali tappe evolutive di presenza dell’uomo sulla Terra e sull’accelerazione che ne ha contraddistinto l’ultimo recente periodo. Il nostro pianeta sembra avere un’età di circa quattro/sei miliardi di anni. L’essere umano è datato intorno a quattro e sette milioni di anni fa. Mentre circa centodiecimila anni fa compare l’Homo Sapiens.
In questo contesto, è possibile individuare tre principali tappe evolutive ‘Ere’, che caratterizzano la presenza dell’Homo Sapiens: contadina, industriale e Antropocene.
Con l’era contadina o agricola l’Homo Sapiens, circa 8000 anni fa, inizia a utilizzare le risorse naturali messe a disposizione dal pianeta Terra, si organizza e si moltiplica. La coltura della Terra permette di passare alla coltivazione dei vegetali e all’allevamento degli animali, dando origine alla prima vera e propria rivoluzione, culturale ed energetica, ‘agricola’.
Circa 200 anni fa, si è avuta una seconda importante rivoluzione, non limitata all’utilizzo delle risorse naturali disponibili come i vegetali, il sole, il vento e l’acqua, che ha introdotto attività di trasformazione energetica. L’era industriale, passando gradualmente e progressivamente dall’utilizzo delle risorse naturali a quello delle risorse fossili e loro trasformazione, determinando una crescita esponenziale.
L’utilizzo delle risorse fossili ha prodotto un inarrestabile aumento del disordine, di tutti quei rifiuti che alterano il naturale equilibrio terrestre con inevitabili ripercussioni sul pianeta e sul suo abitante. Antropocene, termine divulgato dal premio Nobel per la chimica atmosferica Paul Crutzen, per definire l’era geologica in cui l’ambiente terrestre, inteso come l’insieme delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in cui si svolge ed evolve la vita, è fortemente condizionato a scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana.
Nel tempo, soprattutto recente, il disordine antropico ed entropico ha superato e, per certi versi, quasi compromesso l’ordine naturale.
Menti illuminate, quale quella di Aurelio Peccei e studi previsionali avevano preannunciato gli attuali scenari, già circa 50 anni fa nel 1972 con ‘I limiti alla crescita’, evidenziando esigenze irrinunciabili, purtroppo sottovalutate e disattese.
Ogni anno l’economia mondiale consuma quasi 93 miliardi di tonnellate di materie prime tra minerali, combustibili fossili, metalli e biomassa. Il consumo di risorse è triplicato dal 1970 e potrebbe raddoppiare entro il 2050.
Tutto ciò presuppone un approccio olistico, sistematico e integrato, che tenga conto, inter alias, di sostenibilità (equilibrio), resilienza (adattamento) e circolarità (risparmio), dove resilienza e circolarità rappresentano due concetti avanzati, inseriti in quello più ampio di sostenibilità.
Sostenibilità fa riferimento a uno sviluppo che soddisfa le necessità di oggi senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie, garantendo un mondo in uno stato di equilibrio che deve essere mantenuto quanto più stabile possibile.
Resilienza e processi economici sono strettamente connessi.
Se con il termine di resilienza si indica la capacità di un sistema di rispondere in modo adattivo a sollecitazioni o a cambiamenti esterni più o meno traumatici, con circolarità si intende la riconfigurazione dell’attuale sistema produttivo e di consumo attraverso un processo di auto-rigenerazione, in modo che un rifiuto diventi una materia prima.
Tematiche queste centrali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata nel 2015, che declina 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), target e indicatori fondamentali nei diversi settori per garantire il futuro al pianeta e a noi suoi abitanti, e si fonda su tre principi: integrazione, universalità e partecipazione e su quattro pilastri: economia, società, ambiente e Istituzioni.
Il raggiungimento degli obiettivi è possibile solo con l’adozione e l’attuazione di politiche integrate e di comportamenti individuali che abbiano sempre presente sostenibilità, resilienza e circolarità.
Esempio concreto è l’iniziativa della nuova Commissione europea (2019-2024), molto impegnata e determinata sul fronte del raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 e, nello specifico, della Direzione generale salute e sicurezza alimentare (DG SANTE) che, nell’ambito dello ‘European Green Deal’, ha presentato la strategia ‘dal produttore al consumatore’ (from farm to fork)) per migliorare la qualità delle produzioni, così come tutelare l’ambiente e promuovere la sostenibilità dei sistemi alimentari, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori.
È fondamentale considerare l’impatto sull’ambiente dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici, il depauperamento delle risorse naturali e la perdita delle biodiversità.
Come bisogna non trascurare gli ambienti urbani, i nuovi stili di vita e le conseguenti malattie croniche non trasmissibili: respiratorie, cardiovascolari, tumorali e diabete, responsabili del 71% delle morti globali, 80% delle morti premature, uccidendo 41 milioni di persone ogni anno, e promuovere diete salutari e sostenibili, tradizionali, come la Dieta Mediterranea.
Alcuni ricercatori hanno, poi, sottolineato lo stretto legame tra sviluppo, sostenibile, e convivenza in equilibrio con il pianeta e il suo ecosistema. Il rischio di insorgenza di pandemie non dipende di per sé dalla presenza di aree naturali o di animali selvatici, ma piuttosto dal modo in cui le attività antropiche influiscono su queste aree e queste specie, rappresentando un punto cieco (blind spot) nei piani di sviluppo sostenibile, cui non vengono dedicate sufficienti misure di prevenzione.
I disastri, naturali o causati, questi da noi chiaramente, sono causa delle emergenze non epidemiche che come quelle epidemiche, una volta verificatesi, vanno affrontate e gestite.
Tanto, però, può la prevenzione, sostenibile, promuovendo resilienza e circolarità nel mitigare e adattare, fino a trasformare, attraverso la conoscenza e la consapevolezza, alla cui base ci sono la formazione continua e la comunicazione, che permettono di prevedere (forecast), intuire (foresight) e, quindi, anticipare (anticipation) scenari futuri attraverso la pianificazione (piani di azioni – di settore).
“Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte”.
“Per costruire un futuro migliore ci serve un’utopia. Un’utopia sostenibile. È richiesto l’impegno di tutti e un profondo cambiamento del modo in cui leggiamo e affrontiamo i problemi che ci circondano”.
La prevenzione prevede una iniziale e corretta valutazione (assessment) per cui sono fondamentali conoscenza e analisi, seguite poi da pianificazione (planning) e attuazione (implementation), queste in comune con la gestione (management), che si concretizza in preparazione (preparedness) e risposta (response).
La prevenzione e, poi, la gestione delle emergenze in sanità pubblica sono multi, inter e, perché no, trans disciplinari e, grazie alla struttura e all’organizzazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale, sul territorio operano i Dipartimenti di Prevenzione con un ruolo fondamentale, sia nell’ottica dell’approccio ‘One Health’ che di supporto al Sistema di Protezione Civile con la Funzione 2 – Sanità umana e veterinaria e assistenza sociale.
Prevenzione e gestione sono interdipendenti, inversamente proporzionali e in equilibrio critico, come piatti di una bilancia dove il maggiore o minore peso della prima determina e influenza quello della seconda.
Il modo meno costoso per reagire a un evento catastrofico è, in primo luogo, prevenirlo.