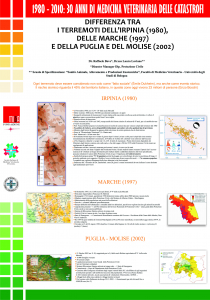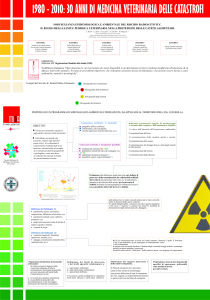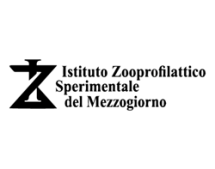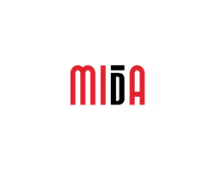di Gennaro Forgione, Dirigente veterinario di sanità pubblica Asl Caserta.
La Centrale Elettronucleare del Garigliano di Sessa Aurunca è stata costruita in quattro anni (1959 – 1963) dalla SENN, Società Elettronucleare Nazionale, ed ha iniziato la produzione di energia elettrica nell’aprile del 1964. La centrale, appartiene alla prima generazione di impianti nucleari, con una potenza di produzione elettrica di 160 MWe. La Centrale era alimentata da un reattore ad acqua bollente con un combustibile costituito da biossido di uranio arricchito. Nel 1965 la proprietà della centrale è stata assunta da Enel. L’impianto è stato in funzione fino al 1978, anno in cui è stato fermato per manutenzione ed ha ottenuto nel 1985 la licenza ad esercire tutte le attività svolte a portare l’impianto in condizione definite di “ custodia protettiva passiva “. Nel 1986 fu predisposto, pertanto, il Piano di emergenza esterna, con riferimento agli incidenti possibili in tale situazioni in particolare con i rischi relativi alla movimentazione del combustibile nucleare ( ancora in parte presente sull’impianto ) ed alla gestione dei rifiuti radioattivi.
Descrizione generale del sito: le caratteristiche oggetto di attenzione riguardano la demografia, le attività agricole e zootecniche, la climatologia, meteorologia, idrologia e la idrogeologia; la Centrale del Garigliano è situata nella valle del fiume Garigliano che segna il confine fra la provincia di Caserta e quella di Latina , nel Comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta a circa 7 Km dal mare Tirreno. La Centrale si estende su una superficie di circa 140 ettari.
Demografia: in prossimità dell’impianto e comunque a partire da pochi chilometri da esso vi sono già le prime abitazioni, considerando poi altri centri abitati in prossimità della centrale come la Frazione di Baia Domitia, San Castrese, Lauro in provincia di ( CE ) , Scauri e Marina di Minturno in prov. di ( LT ). Attività agricola e zootecnica : entro il raggio di 2 Km vi sono in prevalenza le seguenti colture: grano, granoturco, ortaggi pescheti ed albicoccheti; vi è la presenza poi di allevamenti di ovini, bovini suini e bufalini.
Climatologia e meteorologia: i diversi studi meteorologici hanno messo in evidenza una criticità giornaliera associata al regime di brezza si di terra che di mare
Idrologia ed idrogeologia: le acque del fiume Garigliano alimentano una notevole rete di irrigazione con prelievo di due canali principali che derivano la loro portata a monte dell’impianto; sono presenti poi diversi pozzi di cui i poderi sono dotati per irrigare colture ortive e serre.
Situazione Generale dell’impianto: la Centrale oggi è in fase di disattivazione, ferma ormai da oltre quindici anni, è totalmente priva di combustibili nucleari sia fresco che irraggiato con l’allontanamento di oltre il 99% della radioattività presente nell’impianto. Attualmente la Centrale opera in condizioni intrinsecamente sicura ed a rischio radiologico praticamente nullo. Sono state avviate tutte le operazioni di estrazione e condizionamento dei rifiuti solidi radioattivi ad alta attività proveniente dalle attività pregresse, per poi procedere alla estrazione dei rifiuti radioattivi a medio attività. Importante sottolineare che nell’area della Centrale si trova anche il Laboratorio controlli ambientali che in caso di incidente è di supporto al Centro Operativo Interno.
Lo scarico nell’ambiente di effluenti radioattivi liquidi ed aeriformi in condizioni normali è regolamentato da apposite prescrizioni tecniche che limitano la quantità di scorie sacricabili nei diversi periodi dell’anno.. L’influenza sull’ambiente esterno, degli scarichi radiattivi viene controllata da una rete di sorveglianza ambientale gestita dalla SOGIN e sottoposta a controlli periodici dall’ISPRA con funzione di vigilanza.
Detta rete di sorveglianza ambientale consiste in un programma di prelievo ed analisi di matrici ambientali, relative al sito circostante l’impianto.
I rifiuti radioattivi solidi vengono stoccati nell’area della Centrale;
I rifiuti liquidi, costituiti da drenaggi e soluzioni provenienti da operazioni di decontaminazioni e dal laboratorio avviene tramite immissione nel canale di restituzione dell’acqua di raffreddamento del condensatore previo campionamento di analisi radiochimica dei liquidi contenuti nei singoli serbatoi. Gli effluenti radioattivi aeriformi, costituita dal particolato contenuto nell’aria di ventilazione, viene smaltita in continuo tramite un camino previo sempre di un opportuno monitoraggio.
Incidenti di riferimento: con l’attuale stato di disattivazione dell’impianto sono stati presi in considerazione degli incidenti di riferimento. E’ stato considerato quale incidente di riferimento. quello comportante il maggiore rischio di radioattività per l’ambiente esterno.
In particolare, gli incidenti di riferimento sono stati individuati nei seguenti:
- Incidente di scarico di un serbatoio di stoccaggio;
- Incidente di rilascio radioattivo all’ambiente esterno mediante allagamento dei locali interrati;
- Incidente di rilascio radioattivo all’ambiente esterno a seguito di incendio;
I primi due sono da considerarsi come rilasci radioattivi liquidi, mentre quello di tipo C è un rilascio di liquido aeriforme.
Ad esempio, nel caso A, a causa di errori dell’operatore c’è il rischio di scarico diretto nel fiume dell’intero contenuto di un serbatoio con i derivanti rischi per tutto l’ambiente.
Scenario di un eventuale incidente nucleare: un incidente in una centrale nucleare ha un grosso impatto anche sull’ambiente. La zona contaminata si estende per diverse migliaia di chilometri quadrati. La contaminazione diminuisce sensibilmente con l’aumentare della distanza dalla centrale. Anche le acque sono contaminate e trasportano sostanze radioattive che si diluiscono con l’aumentare della distanza dall’impianto. A seconda della sostanza radioattiva liberata nell’ambiente, la contaminazione radioattiva diminuisce più o meno rapidamente. Anche la contaminazione del suolo si riduce già pochi giorni dopo il passaggio della nube. All’interno della zona contaminata, l’economia subisce un arresto temporaneo. Per l’agricoltura viene emanato un divieto di raccolto e di pascolo. Altri settori quali il turismo, l’industria alimentare e certe aziende di produzione sono gravemente colpiti a medio e lungo termine. Il valore degli immobili crolla poiché la decontaminazione delle aree residenziali è estremamente complessa e costosa.
Valutazione del rischio: sulla base delle prescrizioni di sicurezza vigenti in Italia, gli esperti stimano molto bassa la probabilità che si verifichi un incidente in una centrale nucleare, con emissione di una grossa quantità di radioattività. L’entità potenziale dei danni viene invece stimata molto elevata. Il danno totale monetizzato (ossia convertito in denaro per fini comparativi) dello scenario di riferimento si stima in diversi milioni di Euro. Nel rapporto sui rischi, l’entità dei danni per i pericoli analizzati è più elevato per gli scenari di terremoto o mancanza di elettricità. Per lo scenario d’incidente nucleare il valore di rischio è comparativamente più basso. Nei media e nelle discussioni politiche, questo rischio è invece percepito come molto più elevato.